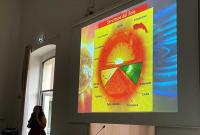Alla Città della Scienza, nel settimo incontro del ciclo "Aperiscienza" per "Il mese della Ciminiera scientifica", è intervenuta Lidia Contarino, ricercatrice in Fisica Solare all’Inaf-Osservatorio astrofisico di Catania
La stella attorno al quale orbitano tutti i pianeti, il Sole, è attualmente nel periodo di massima attività. I brillamenti e le violente esplosioni di plasma provenienti dalla nana gialla continuano a dare spettacolo, attirando l’attenzione anche dei meno esperti, per i loro effetti sul nostro pianeta.
La struttura del Sole è costituita da più strati, tra i quali fotosfera, cromosfera e corona. È proprio dalla corona che si può verificare l’espulsione di materia verso la Terra, causato da un improvviso rilascio di energia in seguito a una tempesta geomagnetica.
Le particelle che vengono emesse sul nostro pianeta possono causare problemi alle reti elettriche, ai gasdotti od oleodotti, danni alle centrali elettriche, disturbi nei segnali di comunicazione e problemi ai satelliti che orbitano intorno alla terra.
Nei periodi di massima attività solare si verificano le aurore polari, il risultato di collisioni tra particelle cariche rilasciate dal Sole (protoni ed elettroni) e particelle gassose nell’atmosfera terrestre che penetrano nella nostra atmosfera.
La colorazione delle aurore polari dipende dagli elementi che vengono colpiti; rossa nel caso dell’ossigeno atomico, verde nel caso dell’ossigeno molecolare e azzurro nel caso dell’azoto.
Questo fenomeno è visibile solo ai poli della terra per via del campo magnetico che influenza il flusso delle particelle cariche dei venti solari e le convoglia verso i poli.
La colorazione rossa del cielo catanese avvenuta a maggio è, invece, stata un esempio di SAR - Stable Auroral Red arches, ovvero il risultato dell’eccitazione dell’ossigeno atomico nell’alta atmosfera, sopra i 300-400km, causata però dalle fasce di Van Allen, delle regioni a forma di ciambella che circondano la terra in cui si accumulano le particelle cariche provenienti dal Sole.
A parlarne è stata la ricercatrice di Fisica solare Lidia Contarino dell’Inaf - Osservatorio astrofisico di Catania impegnata nel progetto di monitoraggio SpaceWeather e della divulgazione scientifica.
Una relazione, alla Città della Scienza dell’Università di Catania, nel settimo incontro del ciclo Aperiscienza per Il mese della Ciminiera scientifica organizzato dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia.

Un momento dell'intervento di Lidia Contarino dell’Inaf - Osservatorio astrofisico di Catania
L’Istituto nazionale di astrofisica comprende sedici osservatori, sparsi in tutta Italia, e «collabora in maniera importante con gli istituti all’estero, infatti, fa parte dei programmi dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) che - ha aggiunto - a sua volta si relaziona con l’Agenzia spaziale europea (Esa) e la National Aeronautics and Space Administration (NASA)».
Non mancano partecipazioni a programmi con gli istituti americani anche se, evidenzia la ricercatrice, sono maggiori le relazioni con quelli europei.
«L’attività divulgativa rientra tra gli scopi che l’Inaf a livello nazionale e l’Osservatorio astrofisico di Catania si pongono - ha spiegato la dott.ssa Contarino -. Bisogna avvicinare i ragazzi alle discipline scientifiche attraverso lo studio del sole e dei pianeti».
«Esporre la disciplina a un pubblico generalista può essere più o meno semplice in base agli argomenti - ha continuato – utilizzare paragoni della vita quotidiana può facilitare la comprensione».
La ricercatrice ha posto l’accento sulla partecipazione rosa alla disciplina scientifica affermando che «all’Osservatorio di astrofisica di Catania ci sono molte donne, in primis la direttrice Isabella Pagano - ha aggiunto - e in molti gruppi di ricerca c’è una consistente quota femminile».
Ultimamente se il numero di donne astrofisiche non è aumentato, è almeno pari a quello degli uomini astrofisici.